Maria Capitanio, brigantessa di San Vittore

Rubrica: «Personaggi,avvenimenti e luoghi del nostro Sud» a cura di Vincenzo Ciorciari
Maria Capitanio, brigantessa di San Vittore

La svolta decisiva nella vita della Capitanio, figlia di un ricco proprietario terriero di San Vittore nel Lazio, avvenne quando si innamorò di Antonio (qualcuno lo dice Agostino) Luongo, prima operaio delle ferrovie e poi brigante. La data di nascita può fissarsi al 1848 o al 1850, giacchè si dice che si innamorò del Luongo nel 1865, anno in cui per alcuni era quindicenne mentre per altri diciassettenne.
La non troppo matura età della ragazza senz’altro contribuì al cosiddetto grande amore per l’uomo, tant’è che, invaghitasi, non se ne staccò nemmeno quando egli si diede alla macchia, lo frequentava di nascosto se poteva girarsi nelle località dei paraggi e lo seguiva quando gli spostamenti dell’uomo si resero più frequenti e i nascondigli più lontani per la sicurezza sua e della banda.
Le “nozze rusticane” che la unirono al brigante amante furono il momento più significativo di una vita in comune molto breve e intensa se non addirittura un lampo di vita. Nel breve tempo mai che avvertisse timore o qualsiasi altro disagio nel partecipare sia alle avventure banditesche che impegnavano la banda, sia prestandosi alla mansione di accudire e vigilare su un ricco possidente caduto nelle mani di quella ed in attesa di riceverne il riscatto.
La troviamo nella battaglia di Monte Cavallo (Terra di Lavoro) e di nuovo siamo al cospetto della “congiura” delle date riguardanti l’episodio.
Alcuni, come Giovanni De Matteo (Brigantaggi” o e Risorgimento – leggittimisti e briganti tra i Borbone e i Savoia – Guida Editore Napoli 2000), credono sia avvenuto il 30-3-1868: nella battaglia di Monte Cavallo del 30 marzo 1868, accanto ai briganti combatterono accanitamente tre donne, Maria Capitanio, Gioconda Marini, Carolina Casale, che rifiutarono di arrendersi.
Altri ritengono il 10 o l’11 dello stesso mese: Dagli atti del processo, celebrato nel 1868, contro la banda Ciccone – Pace, contenuto nella Serie dei Processi Politici e di Brigantaggio della Gran Corte Criminale di Santa Maria Capua Vetere. La ragazza venne “rapita” il 4 marzo del 1868, esattamente sette giorni prima della cattura di tutta la banda Ciccone – Pace da parte del 27° Reggimento di Fanteria … nella battaglia di Monte Cavallo del 10 (?, ndr.) marzo 1868, accanto ai briganti combatterono accanitamente tre donne, Maria Capitanio, Giocondina Marino, Carolina Casale. (CaiazzoRinasce – Piedimonte Matese, la storia di due briganti distribuita dal 12 febbraio all’Archivio di Stato di Caserta. Maria Capitanio, temuta anche a Caiazzo!!! 12-2-2008)
L’avvenimento è di speciale rilevanza per il semplice motivo che, accanto ai capibanda Suppiello e Luongo, vediamo per l’unica volta riunite tre brigantesse, Maria Capitanio, Gioconda Marini e Carolina Casale le quali, non solo si distinsero nella lotta con furore e valore da fare impallidire la fama dei loro colleghi uomini che lasciarono la vita sul campo, ma rifiutarono arrendersi e necessario fu il concorso di molta truppa per averne ragione e ridurle alla prigionia.
Tramandano le cronache che la resistenza più rabbiosa fu espressa proprio dalla Capitanio, dovendo dai militari essere ridotta in catene quale indomabile belva. Da donna del brigante Luongo, che moriva per le ferite riportate in un furioso scontro a fuoco con un drappello di carabinieri, non solo gli subentrò nel comando del gruppo ma, tradizione recita, giurò di vendicarlo ed ammazzare tanti soldati per quante gocce di sangue aveva egli perduto.
Parola che mantenne, dilagando per monti e pianure, sconvolgendo la vita di quanti si trovassero sulla traettoria delle sue scorribande, impegnando con forti perdite materiali ed umane le truppe regolari, compiendo, infine, una sua frequente cerimonia di sangue come fra qualche rigo leggerai.
Leggenda, o meglio, leggende sorsero sui briganti e sulle brigantesse: quelle per ogni paese dove operarono o dove arrivò la loro fama, quelle create da ogni testimone, quelle romanzate su precedenti ascoltate da quel testimone, quelle rabberciate da chi voglia scrivere qualcosa sulle affascinanti figure e non trova materiale sufficiente, quelle rammendate da chi cade nella confusione creata da storici improvvisati. La morale è che le imprecisioni, le confusioni, le approssimazioni sono violenze che i briganti subiscono da morti e che allungano la catena di quelle subite da vivi.
Nel caso della Capitanio non troviamo la parola definitiva su molti momenti delle sue vicende:
si allunga la sua vita con il Luongo da solo sette giorni dal rapimento alla famosa battaglia a fino a tre anni, per chi la vuole innamorata a quindici anni;
qualcuno ci assicura che fu imprigionata sul campo di battaglia e qualche altro che si rifugiò nei boschi a continuare nella guerriglia per vendicare l’amante morto;
ad un primo che ci tramanda che fu scarcerata segue un secondo a sostenere che fu suicida, ma non chiaramente se in carcere prima o dopo della sentenza o una volta resa libera, perchè in tal caso c’è chi la vuole come unica della banda scarcerata.
Si aggiunge, infine, l’enigma del tempo e del luogo della sua morte, ma sembra unanimamente accettato che abbia ingerito pezzi di vetro ma per la disperazione che le causò la scomparsa dell’amante, come rientrerebbe nei canoni romanzeschi preferiti dalla mentalità del tempo, o come estremo atto di denuncia contro le odiate forze occupanti?
L’interrogativo non si sciolse, erano tempi in cui non si riusciva (non i voleva?) a capire che fosse capace di sì nobili e sublimi decisioni una donna dotata di un tipo di avvenenza un po’ torbida, sempre vestita da maschio con catena d’oro sulla giubba di fustagno, come sottolinea Torquato Maiorino (Storie e leggende di briganti e brigantesse, pag. 124 – Piemme 1997). Paradossalmente risultava più difficile figurarsi e capire una donna “maschiaccio” che non una donna “vampiro”, e farne leggenda con un non so che di adesione, stando a quel forte dettaglio dall’Agnoli propinatoci: si diceva, prendeva parte all’uccisione dei prigionieri e degli ostaggi ed era sospettata di mangiare il pane inzuppato nel sangue dei nemici.
L’episodio, oltre a delineare molto precisamente la protagonista, è degno di menzione e di ulteriore sviluppo perchè non fu unico ma uno dei tanti, come altri due che in seguito riporto dalla d’Uggento, che autorizzano parlare di una pratica ricorrente e che, per l’appunto, assume il carattere di un vero e
proprio rituale, “spettacolarizzato” dalla cerimonia inscenata dall’ingeritore di emoglobine.
Ne furono informati anche gli integranti della Commissione Massari sul brigantaggio e infatti nella relazione posero speciale enfasi sulla vigliaccheria bellica, sulle costumanze antropofaghe, sui comportamenti più risaltanti della loro indole selvaggia, incorregibile e perniciosa per la società:
Noi non vogliamo funestarvi, o signori, con la narrazione delle atrocità che i briganti commettono sugli infelici che cadono nelle loro mani. Più che opera di creature umane sembrano essere quelle di cannibali e di belve selvagge … Né la stessa morte della vittima appaga e stanca la ferocia dei masnadieri, i quali sfogano la libidine di sangue da cui sono invasati anche contro i cadaveri. […] Sono rotti ad ogni lascivia e turpitudine, pronti ad ogni delitto: bevono il sangue, mangiano carni umane. Sono rozzi, superstiziosi, ignoranti. (Commissione Parlamentare- Il brigantaggio nelle province napoletane: relazione dei Deputati Massari e Castagnola colla legge sul brigantaggio – Fratelli Ferrario Milano 1863)
A seconda della sensibilità di chi vi assistesse o di ciò che avesse interesse di dimostrare chi ne scrivesse, assumeva il cerimoniale diversi contenuti e significati che solo potrebbe spiegare un antropologo di autorevole e sperimentata dottrina, ma accontentiamoci delle convinzioni “popolari”, per quanto bislacche, certo meno pericolose di quelle di stampo lombrosiano che circolavano.
Vi è chi sostiene una barbarie istintiva e gratuita della quale sarebbe fuorviante inventarsi spiegazioni e motivazioni; vi è chi pensa ad un paganesimo o sincretismo non definitivamente scomparsi tra gli abitatori di quei paesi non ancora presi in considerazione dalla Storia; vi è chi scopre commistione di esorcismi e propiziazioni per liberarsi dall’oppressore e suoi rappresentanti; vi è chi scorge un duplice messaggio, inviato all’esterno per informare il nemico della tempra e del valore di chi combatte sul fronte opposto e comunicato all’interno della banda per affermare il ruolo di capo e far desistere voglie di rivalità e di congiure; vi è chi azzarda esagerate rappresentazioni di tragicità ed esasperati deliri di truculenza di attori che si sforzano di nascondere la paura che li avvolge e sconvolge come protagonisti.
Si potrebbero, comunque, teorizzare altri significati e pure ben ragionarli, ma, se difficile era penetrare fisicamente tra quei boschi per catturare i briganti, risulta ancora più difficile penetrare nell’intimità recondita dei briganti e della gente che li conosceva, li amava, li proteggeva, ne raccoglieva le confessioni tra una sbornia per festeggiare episodi di vittoria ed un’altra per leccare ferite di sconfitta.
Resta l’interrogativo che suggerisce riflessioni forse assurde, surreali, “scarfogliesche”, di moda un tempo e con una buona dose di coraggio tuttora condivisibili: il sangue del Sud sempre è stato prezioso, ma sempre è costato poco e sempre l’han pagato ancora meno ed a proprio capriccio quelli che furono e sono gli sfruttatori dal Sud. Stomaco forte per il sangue e pazienza ancora più forte per una divagazione dialettale: t’aggia suca’ u sango (“ti succhierò il sangue”) è la peggiore minaccia che si possa fare ad una persona, anche se spesso perde il proprio tremendismo nella innocente parlata infantile; si suca u sango r… (succhia il sangue di…) è riferito al profittatore, al parassita, all’usuraio nel senso che è facile intendere.
La similitudine concettuale delle colorite espressioni in vernacolo, che variano da paese in paese, pur avendo ovviamente perduta la forza lessicale originale, non lascia del tutto tranquillo l’interlocutore, ma quanto peggio si sentiva chi cadeva nelle mani della Capitanio o della Colacicco o della Giannico:
Caterina Colacicco di Gioia Del Colle, non brigantessa ma moglie del bandito Nicola Lillo, che intinse, secondo il racconto che ne fa lo storico Nicola Lucarelli, il pane nel sangue del paesano e garibaldino che lo aveva arrestato, Vincenzo Pavone, linciato in piazza, e se ne cibò. O una certa Margherita Giannico che anche lei, secondo il racconto di Carano Donvito, intinse le dita nel sangue della vittima e se le succhiò “cannibalescamente… (Maria Rosaria d’Uggento – Un popolo di lazzaroni, pagg. 97 – Editrice UNI Service Trento 2011).
Tutti d’accordo invece che il padre, al quale non mancavano risorse, già prima del processo cominciò a procurarsi testimoni comodi e coscienziosi nel testimoniare che la figlia, pur convivendo con il brigante, non aveva mai e in nessun modo partecipato alle operazioni della banda e del suo capo, tutt’alpiù in qualcuna sarebbe stata presente non per sua volontà ma obbligata.
Risulta che il Tribunale di Isernia accolse la linea della difesa, supportata dalla cauzione di 1.500 lire pagata dal genitore, e la prosciolse da ogni imputazione, ma i pezzi di vetro, che di sicuro non si sa quando ingoiati, di sicuro posero fine alla vita della giovanissima Maria, una delle “donne dei briganti”.


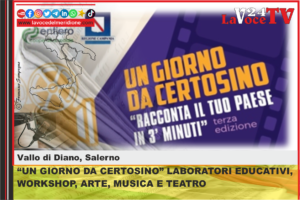



Rozzi ,superstiziosi e ignoranti,sicuramente sempre loro la gente del Sud,gente che difendeva la propria terra.
Ma come si dovrebbero descrivere,coloro che invocano le deità cosicché il Vesuvio,l’Etna li lavasse col fuoco?